EDITORIALE
Carlo Melodia
Le radici culturali del metodo della medicina omeopatica
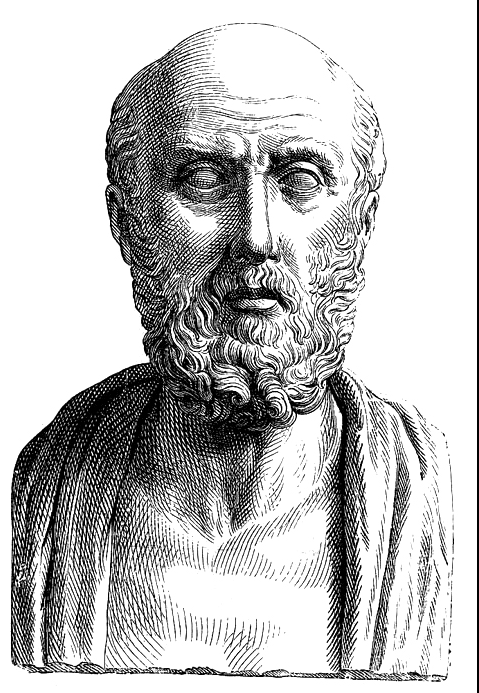
Ippocrate di Cos (460-377 a.C.)
Premessa
C.F.S. Hahnemann (1755-1843) al culmine della sua carriera di letterato, chimico, farmacologo e medico-chirurgo e nonostante i riconoscimenti professionali che possiamo leggere in questo blog[1] non si arrese mai alla sua aspirazione: quella di curare i singoli fratelli malati senza affidarsi a formule mediche dogmatiche prescritte secondo indicazioni empiriche e non sperimentate ma soprattutto decise sul nome della malattia e sui suoi sintomi comuni, come emerse dalla prima materia medica di Dioscoride.
Il passaggio dalle cure del malato a quelle della malattia rappresentò una profonda trasformazione del pensiero medico in senso restrittivo. Infatti, dalla visione olistica del mondo si isolò solo un aspetto scollegato dal tutto riducendo la complessità della vita in un rapporto di causa ed effetto tra l’etiologia della malattia e i suoi sintomi comuni a tutti i portatori della stessa e il farmaco. Tutto ciò paradossalmente avvenne con la scoperta della logica aristotelica che ridusse l’osservazione del malato e la sua conoscenza al riconoscimento di sintomi comuni osservati e descritti precedentemente in quadri nosografici: secondo descrizioni chiamate “malattia”.
Dal riduzionismo di questo passaggio malato-malattia, essendo questa ultima una entità astratta perché circoscritta e non biologicamente autonoma come lo è il malato, emerge che il principio terapeutico, il vitalismo autonomo o omeostasi, viene abbandonato per una via diretta ad eliminare i sintomi della malattia; tralasciando il potenziale naturale che va solo sostenuto nella sua attività riparativa.
Hahnemann trovò, nella dottrina di Ippocrate, la risposta metodologica per la cura del malato assieme al principio di similitudine utilizzato empiricamente da Ippocrate e poi usato via via nella storia della medicina; come possiamo leggere in altro editoriale sempre sul “tema del giorno”.
Paradossalmente, chi si opponeva all’omeopatia, ovvero i medici dell’antica scuola, si definivano ippocratici senza neanche conoscere il senso dottrinario della affermazione che presuppone la cura del malato attraverso la Vis medicatrix naturae, ovvero il vitalismo e l’omeostasi.
Da Ippocrate ad Hahnemann
Le radici filosofiche e metodologiche[1]
Il metodo della medicina omeopatica, per apprezzarlo nella essenza del suo significato unitario ed autonomo, deve essere studiato in una modalità di approccio che necessita di una premessa filosofica.
Infatti, questa metodologia in medicina non può essere né spiegata e neppure compresa, di conseguenza, attraverso una semplice applicazione del pensiero o del linguaggio meccanicistico che sostiene il metodo allopatico o convenzionale.
La cultura medica dominante, infatti, nel suo riduzionismo non può evidentemente contenere la visione unitaria propria della metodologia omeopatica e, di conseguenza, quest’ultima non trova nella tesi riduzionista allopatica una possibilità di interpretazione.
Come vedremo in dettaglio, Hahnemann ruppe, ad un certo punto della propria esistenza, con il pensiero medico del suo tempo per una insoddisfazione interiore che nasceva dalla mancanza di riferimenti della medicina, da lui praticata nella prima parte della sua vita professionale, che identificassero le esigenze del singolo malato.
Solo attraverso l’abbandono dei presupposti della visione medica organicista e riduzionista Hahnemann ritrovò l’identità esistenziale nella condivisione del vecchio, ma non superato, modello Ippocratico.
Proprio nella visione neo-ippocratica fu possibile ad Hahnemann riconoscere, con il metodo della osservazione imparziale, i fenomeni in natura attraverso i quali perfezionò l’uso del principio di similitudine con la sperimentazione di droghe sull’uomo sano. Esse diventarono rimedi dopo le verifiche cliniche di efficacia sui malati e quindi il mezzo di cura di ogni singola persona umana nello stato di malattia espresso individualmente e in modo peculiare.
Soltanto con una impostazione preliminare e imparziale di tipo neo-ippocratico, come fece Hahnemann, si potrà quindi proseguire nello studio che abbiamo intrapreso e cogliere, nel metodo sperimentale unitario della medicina omeopatica, quella autonomia che la caratterizza.
È interessante sottolineare che la dottoressa A. Rodríguez [2], fondatrice e Presidente della nostra scuola, richiedeva fermamente allo studente, per il fine a cui aspira, di auto osservarsi e abbandonare i preconcetti acquisiti in campo medico e affrontare lo studio del metodo omeopatico in piena libertà ideologica affidandosi in prima istanza all’intelletto e solo successivamente a servirsi della ragione per la scelta individuale di cura del singolo malato.
Ragione e Intelletto secondo i neoplatonici
«La Ragione non può cogliere l’unità delle cose, poiché il suo ufficio è di cogliere le divisioni, di mettere ordine: spetta invece all’Intelletto afferrare intuitivamente l’unità che soggiace al molteplice».
Risulta quindi indispensabile avvicinarsi alla conoscenza, in senso lato e in ogni caso, quindi senza il filtro limitante della ragione preconcetta.
L’apprendimento consiste dunque nello scoprire una relazione diretta e di verifica tra la percezione che è in noi e l’oggetto che si vuole conoscere.
Di conseguenza è necessario trovare sempre una assonanza tra ciò che è già potenzialmente nella nostra conoscenza e il mondo che desideriamo scoprire; innanzitutto va quindi compreso il significato unitario di ciò che osserviamo. Ogni scoperta, quindi, rappresenta prima il risultato di una visione intuitiva per diventare successivamente una realizzazione o fase di verifica oggettiva che porta alla sua evidenza.
L’apprendimento dunque passa sempre primariamente dalla funzione tipicamente intellettiva degli eventi considerati.
La funzione basilare dell’intelletto infatti è quella di cogliere il significato che soggiace al molteplice che viene osservato e di trovare quindi, in ogni singolo componente dell’evento, un aspetto funzionale e relazionale al tutto a cui appartiene.
Solo successivamente all’applicazione dell’intelletto è possibile la formulazione di leggi e di principi di ciò che viene osservato attraverso l’uso consapevole della ragione.
Naturalmente in medicina il ruolo del medico assume, nella visione unitaria della persona, una connotazione essenzialmente umanistica che va dalla osservazione complessiva del malato fino alla formulazione individualizzata delle necessità di cura dello stesso; applicando quindi in successione sia l’intelletto che la ragione di conseguenza.
Nella storia della medicina la scuola medica di Ippocrate rappresenterà il primo esempio, ed il più apprezzato, di una impostazione medica che vedeva, nella centralità del malato e non della malattia, la finalizzazione della ricerca e del proprio operato.
L’insegnamento di Ippocrate
rappresenta un riferimento etico per tutti i medici
L’insegnamento della dottrina medica di Ippocrate ha comunque assunto, in campo medico, un carattere di riferimento universale in quanto ha rappresentato e rappresenta, per la sua impostazione metodologica, una visione nobile soprattutto in termini etici.
Infatti, è facile ritrovare, nella visione Ippocratica, quella analogia con l’aspirazione che ha permeato ogni persona umana nell’ambito della professione medica: “curare l’uomo malato”.
Infatti, nonostante le diverse strade ed impostazioni metodologiche seguite, la classe medica indistintamente riconosce in Ippocrate la guida etica indiscussa e formula il proprio “giuramento” professionale recitando il pensiero di colui che viene considerato “Il” Maestro indiscusso dell’arte medica.
La centralità del pensiero di Ippocrate
Il malato e non la malattia
A questo punto risulta evidente che la visione unitaria del mondo vede, nelle parti che concorrono a formare il tutto, un complesso dinamico finalizzato a relazionarsi in modo peculiare per la funzione del sistema.
In questo modello, come confermato dalle acquisizioni della Fisica (Heisenberg[3]), non esiste uguaglianza né uniformità ma solo “probabilità” spazio-temporali in relazione dinamica fra loro.
Questa concezione che animava la visione di Ippocrate e rappresentava la centralità del suo pensiero, fa emergere prepotentemente il concetto di malato piuttosto che quello di malattia.
Naturalmente il malato nella sua sofferenza si rappresenta in modo “unico e irripetibile[4]”.
Mentre la malattia, come risulta intuitivo, accomuna artificialmente tutti i malati che presentano un minimo comune denominatore di quei sintomi cosiddetti comuni; perché appartenenti a tutti coloro che sono sofferenti di quella certa malattia. È evidente che i concetti di malattia e uniformità risultano una forzatura artificiosa e impraticabile alla luce della peculiarità di ogni persona umana e di sistema organizzato in genere.
Il malato, infatti, va considerato unitariamente nella sua sofferenza “irripetibile”, soggettiva e oggettiva.
Questo tipo di approccio medico, dove l’elemento più importante è rappresentato dall’uomo nella sua “complessità unitaria” e quindi di “peculiare esclusività”, prende il nome di “olistico”.
La visione olistica
Il termine “olistico” deriva dalla parola greca “όλων – holon” che significa qualcosa che contemporaneamente rappresenta una parte e il tutto.
In particolare, l’approccio medico “olistico” rappresenta una modalità di comprensione delle circostanze complessive osservate in cui il “malato” viene descritto nella sua sintomatologia analitica soggettiva e oggettiva in una correlazione necessariamente unitaria.
Ciò significa che ogni aspetto sintomatologico non può essere considerato dal medico come un quid separato e di possibile valutazione indipendente ma come qualcosa da dovere valutare solo unitariamente in rapporto di coerenza con gli altri sintomi; con i quali concorre a determinare l’immagine umana da curare.
Solo secondariamente a questo tipo di osservazione del malato, minuziosa ma complessiva in termini dinamici e reattivi, si potrà e si dovrà far scaturire una diagnosi esclusiva di sofferenza di quella persona umana malata.
Nella visione olistica, quindi, la malattia diagnosticata come entità nosografica perderà, in questa modalità di approccio medico, il carattere di uniformità e artificiosità per assumere, nella visione unitaria del malato, le sembianze umane, uniche e irripetibili, del portatore della stessa!
La visione olistica ippocratica
Possiamo identificare dunque la visione di Ippocrate, in termini filosofici, con l’approccio olistico.
La scrupolosa attenzione ai sintomi del malato aveva la finalità di trovare il collegamento di congruenza dei sintomi soggettivi e oggettivi con il tutto rappresentato dalla persona umana unitariamente; nella sua relazione psichica, fisica, relazionale, storica ed evolutiva.
Per questa finalità, Ippocrate invitava fermamente i medici della sua Scuola ad effettuare una indagine attenta e minuziosa del malato.
Questa indagine doveva risultare complessiva e relativa a fare emergere una dimensione spazio-temporale unitaria e quindi dinamica ed evolutiva del malato nel suo ambiente; come risulta essere naturale nella vita di ogni persona umana.
Negli scritti di Ippocrate risalta proprio la minuziosità dell’osservazione ma soprattutto il fatto che non si tratta di una semplice analisi ma di una correlazione tra sintomi, relazioni e reazioni, che hanno la finalità di fare emergere quel quadro di sofferenza, “unico e irripetibile”, che caratterizza ogni singolo malato e lo identifica, di conseguenza, con la terapia necessaria individuale!
«Questi i fenomeni relativi alle malattie, dai quali traevo le conclusioni, fondandole su quanto c'è di comune e quanto di individuale nella natura umana; sulla malattia, sul malato, sulla dieta e su chi la prescriveva [...]; sulla costituzione generale e specifica dei fenomeni atmosferici e di ciascuna regione, sui costumi, il regime, il modo di vita, l'età di ognuno; sui discorsi, i modi, i silenzi, i pensieri, sul sonno e sull'insonnia, sui sogni – come e quando – sui gesti involontari [...] e sulla concatenazione delle malattie – quali derivino dalle passate e quali si generino in futuro. [...] Sulla base di tutto ciò, si estenda l'analisi anche a quanto ne consegue», (Ippocrate Epidemie, 1, 23).
Con queste indicazioni Ippocrate sottolinea il fatto che, oltre alla reazione propria della specie che si presenta con sintomi comuni in tutti gli ammalati di quella malattia, comune è differente da uguale, il medico deve rilevare e indagare:
1) sulla sintomatologia individuale che caratterizza il malato,
2) sulla costituzione,
3) sulle malattie precedenti,
4) sulle circostanze e abitudini,
5) sull’ambiente in cui vive il malato, al fine di comprendere la valenza dell’ambiente socioculturale, atmosferico e alimentare, in relazione alla sofferenza soggettiva e oggettiva vissuta nello stato di malattia,
6) sulla relazione tra terreno biologico predisponente e gli stimoli ambientali e valutare la predominanza di questi o di quelli per determinare se la sofferenza è causata:
a) solo da cause esterne: malattia acuta propriamente detta,
b) solo da cause predisponenti: malattia cronica,
c) dalla concausa di stimoli ambientali e predisposizione: malattie acute da aggravamento dello stato cronico.
Ippocrate invita quindi il medico a tralasciare ogni preconcetto nell’esame del paziente e anche ad iniziare detto esame come se si fosse di fronte ad un nuovo campo di esperienza da descrivere come puro osservatore; “canale vuoto[5]”.
Solo dopo avere acquisito un quadro completo che rispecchia fedelmente la natura complessiva di quella persona umana “immersa unitariamente nelle proprie circostanze[6]” il medico dovrà indicare individualmente le cure, come vedremo.
L’insegnamento di Ippocrate
Il medico deve essere scienziato e quindi consapevole della complessità e della peculiarità
insita in ogni sistema
Dall’insegnamento di Ippocrate emerge prepotentemente una figura di medico scienziato ovvero padrone della conoscenza in senso lato; dalla medicina, alla matematica e fisica, fino alla filosofia.
L’osservazione del malato veniva effettuata da Ippocrate dapprima come analisi imparziale e successivamente come una sintesi della conoscenza unitaria che includeva anche le circostanze ambientali in tutte le loro dimensioni e implicazioni relative alla vita.
In generale il medico olistico, in questa sua attitudine alla conoscenza unitaria dei fenomeni percepiti dall’intelletto, ricercherà comunque una sintesi con la ragione, sempre sul piano unitario, di relazioni da riportare nell’ambito di leggi e principi-guida stabili e verificabili nel tempo.
Inoltre, secondo Ippocrate, il medico non deve mai delegare la propria ricerca ad artefatti concettuali precostituiti in sostituzione della propria osservazione diretta; ma di volta in volta egli deve, dalla sua ricerca imparziale, fare emergere un quadro “unico e irripetibile” di malato e identificare le necessità dello stesso attraverso leggi e principi applicabili per ogni persona umana individualmente; come farà poi Hahnemann.
Per operare in tal senso quindi il medico, nella concezione ippocratica, deve aprirsi all’imparzialità dell’assenza di preconcetti e deve trovare sempre, in ciò che osservava, la relazione dinamica unitaria che soggiace ai fenomeni osservati.
La considerazione filosofica a cui si riferisce la visione “olistica”, propria della medicina ippocratica, consiste nel fatto evidente, non solo negli organismi viventi, ma presente in ogni punto dell’universo, dall’atomo in poi, che un “sistema” nel suo dinamismo rappresenta più della semplice “sommatoria” delle singole unità che lo compongono e che non esistono in natura sistemi chiusi e quindi isolati!
Di conseguenza, nella medicina di Ippocrate, diventa fondamentale per il medico avere una visione unitaria del mondo perché solo in questo tipo di approccio egli potrà trovare le spiegazioni dei fenomeni osservati.
Invece la semplice scomposizione o analisi statica, anche quella più raffinata, non potrà mai fornire indicazioni unitarie ma solo parcellari allontanando l’indagine del medico dalle necessità esclusive di chi soffre.
Infatti Ippocrate è consapevole che ogni sintomo della malattia, se scollegato dal resto della dinamica dell’organismo in toto, di cui fa parte, perde il senso dell’unità in termini di relazione e di movimento e non può descrivere e ritrovare le necessità individuali del malato.
Di conseguenza, nella visione riduzionista, il sintomo parcellare legato alla diagnosi di malattia, visto come causa di se stesso e quindi isolatamente dagli altri sintomi, non potrà mai dare indicazioni sulle cause che lo sostengono e in definitiva da qui risulterà impossibile poter risalire alle stesse e curarle!
Una sintesi mirabile ad esemplificazione della visione di Ippocrate: «Per ciò che riguarda la natura, esamina che cosa mai dicono Ippocrate e il ragionamento veritiero. Non occorre forse ragionare così riguardo alla natura di qualsiasi cosa? Innanzitutto, bisogna vedere se l’oggetto di cui vorremo essere esperti noi stessi e capaci di rendere tale un altro è semplice o multiforme. In secondo luogo, qualora sia semplice, occorre esaminare quale potenza abbia per natura, a che cosa si rivolga quando è attivo o da che cosa dipenda quando è passivo. Qualora invece abbia molte forme, dopo averle enumerate, bisogna esaminare ciascuna di esse come si è fatto per la forma unica, per vedere con quale forma ciascuna agisca naturalmente e che cosa faccia, o con quale forma subisca, che cosa subisca e per effetto di che cosa» (Fedro Platonico).
Come è evidente dal pensiero di Ippocrate egli è consapevole del fatto che ogni sistema assume proprietà e caratteristiche non correlabili alle caratteristiche e proprietà delle singole parti quando queste si integrano e concorrono in modo dinamico alla funzione del sistema.
Nel nostro caso, il sistema è rappresentato da un organismo, persona umana, dotato di corpo, di relazioni e di pensiero.
Le linee guida del vero medico
I medicamenti e le “cure”
Metodo induttivo e deduttivo
Ippocrate critica ogni tentativo riduzionista da parte del medico.
La scuola di Ippocrate prevalse su quelle del suo tempo proprio perché si occupava dell'uomo ovvero del suo modo peculiare di soffrire nell’ambito di una certa malattia.
Secondo Ippocrate il medico doveva essere fornito di una conoscenza universale e di una grande capacità di osservazione (secondo il metodo induttivo) ed essere in grado quindi di correlare tutti i fenomeni e tradurli in leggi e principi.
- Il metodo INDUTTIVO: stabilisce che le leggi e i principi conoscitivi vengano assunti in seguito all'esperienza.
- Il metodo DEDUTTIVO: stabilisce che le leggi ed i principi siano preesistenti alla verifica sperimentale e guidino alla lettura di ciò che viene osservato.
Inoltre il medico doveva conoscere l’azione dei medicamenti secondo una esperienza empirica e somministrarli con “parsimonia” insieme a tutte le altre “cure”; dall’attività fisica, all’alimentazione, al comportamento etc.
Già all’epoca di Ippocrate, il principio di similitudine era stato utilizzato in modo empirico (uso dello zolfo, dell’arsenico, dell’Helleborus, dell’Agaricus etc.).
Ciò fu possibile utilizzando le sostanze, di cui si conosceva la peculiare tossicità, in modo grezzo e in piccole dosi.
È interessante notare che il principio di similitudine usato all’epoca di Ippocrate fu ripreso successivamente da Hahnemann.
Si legge proprio in uno scritto del padre della Medicina Omeopatica: «Già l’autore del Trattato delle epidemie attribuito ad Ippocrate, parla di un colera morbo che resisteva a tutti i rimedi, e che fu dissipato usando solamente l’elleboro bianco[7], che ciò nulla ostante eccita esso pure il colera, come osservarono Forest, Ledel, Raimann e parecchi altri[8]».
Etica e deontologia medica
Il concetto di malato: sin dal tempo di Ippocrate ha rappresentato il travaglio centrale di ogni medico
Esiste una vera e propria conflittualità in ogni professionista sanitario tra l’ “istinto” olistico (etico) ed il pragmatismo riduzionista (spesso dettato da regole deontologiche) come viene Illustrato anche da molti illustri medici e maestri del nostro tempo; è un istinto umano e quindi non viene determinato dalla ragione.
In particolare, proprio l’attualità storica, in cui la scienza e la tecnologia sembrano avere un ruolo irrinunciabile, risulta caratterizzata, ad ogni livello, da un profondo stato di insoddisfazione da parte dell’uomo, in particolare del medico, in quanto egli percepisce una enorme dissonanza tra la propria sensibilità etica e la realtà; spesso l’insoddisfazione in molti diventa frustrazione professionale.
Tutto ciò avviene in quanto il libero arbitrio è sempre più sopraffatto dai dogmi di una scienza imperfetta e mutevole, come la storia della ricerca, in ogni campo, ci ha insegnato.
L’intelletto umano infatti fa riferimento sempre di più, spesso acriticamente, ai modelli matematici che, nati come mezzi al servizio della conoscenza, hanno man mano assunto una connotazione di verità assoluta e stabile nel tempo.
Mentre è ovvio, al semplice buon senso, che tutta la conoscenza è solo e semplicemente una rappresentazione, in assonanza alla evoluzione del pensiero, creata dall’uomo; come tale deve restare al servizio del suo libero discernimento.
In particolare, la mancanza di un metodo in medicina con l’obiettivo primario della cura della sofferenza, intesa come percezione individuale della persona umana, fa nascere nel medico attento al malato, inteso come individualità irripetibile, una conflittualità sul piano etico e deontologico.
- Il primo piano, quello etico, si identifica con la sensibilità umana e professionale del sanitario supportata dall’esperienza.
- Il secondo piano, quello deontologico, indirizza i comportamenti professionali e le obbligazioni terapeutiche, anche in termini di utilizzo di protocolli standard, in una certa attualità storica.
Le obbligazioni deontologiche, come abbiamo letto nell’introduzione, finiscono per togliere al medico quella discrezionalità di intervento peculiare sul malato che è propria dell’arte medica e lo costringono, d’altra parte, a diventare prescrittore acritico secondo quella indicazione terapeutica pregiudizialmente prevista dal protocollo in auge collegato allo stato di quella malattia.
Naturalmente il protocollo terapeutico, previsto aprioristicamente per una certa malattia il più delle volte genera effetti indesiderati nell’organismo su piani differenti.
Di conseguenza, come è possibile osservare e valutare in campo professionale, i protocolli sono variabili nel tempo perché diventano più o meno presto criticabili in termini di efficacia e soprattutto in termini di affidabilità dagli stessi operatori!
Nella professione medica, infatti, tutto ciò è sempre più evidente in quanto l’individualità della persona umana e del malato sembrano lontanissime dall’accettare protocolli di cura “scientificamente” preconfezionati e ritagliati su modelli astratti e generici chiamati comunemente malattie.
Il numero delle stesse, malattie e sindromi, va ampliandosi proporzionalmente con l’aumentare della sensibilità dell’indagine diagnostica; questa è in grado di fotografare solo i risultati di cause complesse e individuali che vengono riportati artificialmente in un quadro uniforme; senza recepirne così i tratti peculiari presenti in ogni persona umana sofferente di una certa malattia descritta secondo nosografia.
Da qui le reazioni avverse, a breve termine, e le complicanze e il deterioramento dello stato complessivo del malato, a medio e lungo termine, secondario anche e alle volte determinato (iatropatie) dalle cure farmacologiche; mirate esclusivamente alla malattia.
Infatti, l’individualità della persona umana, dotata di spirito, mente, corpo e relazioni ambientali in sintonia unitaria, non può essere interpretata in modo parcellare come avviene nella astrazione del concetto di malattia.
In questo caso infatti i presupposti scientifici, che si basano sulla prevedibilità e ripetibilità di un certo evento, in date condizioni (uniformi nel modello di malattia), non tenendo conto delle variabili proprie ed intrinseche al concetto di persona umana, non trovano alcuna applicazione.
Medicina: arte e scienza umanistica
L’arte medica si conferma, in ogni caso, appartenere sempre più alla visione umanistica (metodo induttivo).
Solo in questa visione si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici; affermando così il primato del discernimento umano nella scelta del mezzo terapeutico e non l’obbligo acritico perché precostituito da ipotesi pseudoscientifiche non praticabili per l’imprevedibilità propria della vita stessa.
Un discorso diverso vale per la medicina nelle malattie acute, complicate e degenerative, come anche la chirurgia di emergenza e ricostruttiva; essa può essere definita opera benemerita quando può salvare vite umane o restituire la funzionalità ad organi vitali.
Conclusioni
Etica e deontologia dovrebbero poter essere l’espressione l’una dell’altra, ovvero la terapia dovrebbe corrispondere alle reali necessità individuali dell’ammalato per ristabilire la salute e sempre conseguenti all’imperativo:
“primum non nocère”.
«Il primo passo nell'evoluzione dell'etica è un senso di solidarietà con altri esseri umani», Albert Schweitzer (1875-1965), medico, teologo, missionario tedesco; Premio Nobel per la pace 1952.
[1] Da: CORSO DI MEDICINA OMEOPATICA PER FARMACISTI ANNO I A CURA DI CARLO MELODIA.
[2] A. A. Rodriguez – Lezioni presso la LUIMO.
[3] Werner Heisenberg, principio di indeterminazione, 1927.
[4] A. A. Rodriguez – Lezioni presso la LUIMO.
[5] A. A. Rodriguez – Lezioni presso la LUIMO.
[6] T. P. Paschero – Lezioni presso la LUIMO.
[7] Helleborus foetidus, Helleborus niger, Helleborus orientalis, Helleborus viridis (famiglia delle ranuncolacee: con questi rimedi gli omeopati hanno curato malati di colera – N.d.A.).
[8] Hahnemann, Esposizione della Dottrina Medica Omeopatica II – Esempi: di guarigioni omeopatiche effettuate involontariamente dai medici dell’antica scuola, 1833.
[1] https://www.luimo.org/news-luimo/cristiano-federico-samuele-hahnemann-uomo-chimico-e-medico

